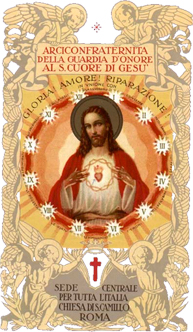Transenne di fronte alla scalinata, un cordone delle forze dell’ordine davanti al portone di ingresso, poliziotti in tenuta antisommossa con scudi e caschi. Tanto è stato necessario per proteggere la Cattedrale di Nostra Signora del Carmelo a Montevideo, in Uruguay, che per il terzo anno consecutivo è stata bersaglio delle femministe in marcia per l’8 marzo. La facciata della chiesa è stata vandalizzata con bombe di pittura rossa e i poliziotti per ripararsi si sono dovuti rifugiare all’interno dell’edificio.
Transenne di fronte alla scalinata, un cordone delle forze dell’ordine davanti al portone di ingresso, poliziotti in tenuta antisommossa con scudi e caschi. Tanto è stato necessario per proteggere la Cattedrale di Nostra Signora del Carmelo a Montevideo, in Uruguay, che per il terzo anno consecutivo è stata bersaglio delle femministe in marcia per l’8 marzo. La facciata della chiesa è stata vandalizzata con bombe di pittura rossa e i poliziotti per ripararsi si sono dovuti rifugiare all’interno dell’edificio.
Da Montevideo a Madrid, da Buenos Aires a Washington, da Roma a Milano, anche quest’anno abbiamo avuto le marce femministe. O meglio «transfemministe», dicono gli organizzatori. Il comitato promotore di Non una di meno non è altro che il “figlio” del #Metoo italiano, “nipote” della rete Se non ora quando, “cugino” della #sistersmarch di due anni fa a New York, eccetera.
Anni diversi, città diverse, stessa coreografia – per il corteo è stato scelto un colore che rappresenta proprio gli stereotipi che si afferma di voler combattere: il fucsia – e stessa regia: si scende in piazza «contro il patriarcato», «contro il lavoro produttivo e riproduttivo», «contro ogni fascismo», «contro l’obiezione di coscienza», «contro l’eterosessualità come norma», contro il politico di turno (purché non sia di sinistra!): quest’anno è Salvini, qualche anno fa era Berlusconi, oltreoceano è Trump, domani chissà.
E lo si fa sempre nello stesso modo: con slogan fuori dal tempo. Riportiamo dai volantini ufficiali: «Le donne partigiane lo hanno insegnato, il vero nemico è il patriarcato»; fuori tema e anche fuori di senno. E poi: «Unici stranieri gli sbirri nei quartieri».
Donne rigorosamente armate di cartelli con riferimenti sessuali di ogni ordine e grado, volgarità di ogni colore e forma, insulti e oscenità in abbondanza. Come se la presunta disuguaglianza si potesse colmare esprimendosi come degli scaricatori di porto.
Ma anche quest’anno siamo andati oltre e, se in America Latina vengono puntualmente attaccate le chiese, anche i cortei italiani di venerdì scorso ci hanno regalato il solito florilegio di offese alla Chiesa. La prima a essere presa di mira – ça va sans dire – è la Regina del Cielo, la Vergine Maria, orrendamente offesa su manifesti e cartelloni come in un gesto di ribellione arrogante nei confronti di una creatura così luminosa che perfino chi la detesta non riesce a ignorare.
E poi Dio, naturalmente. Quest’anno, in diretta televisiva, abbiamo avuto pure il cartello con una bestemmia. Il fotogramma scorre veloce: una ragazza come tante, sulla ventina, con il foulard fucsia, il trucco, i capelli scuri e il sorriso fiero sul volto mentre sorregge il cartello contro Dio. Come ci siamo arrivati?
Forse passando per la senatrice del Pd, Monica Cirinnà, che altrettanto orgogliosamente si fa fotografare sorreggendo un cartello che sputa su Dio, sulla famiglia, sulla patria.
Poi tenterà di correggere il tiro scrivendo sui social: «La mia critica non va né alla Chiesa, né alla patria, né alla famiglia. Con quella foto ho denunciato il riciclo di uno slogan fascista, criticando chi di quei tre concetti si fa scudo per creare un clima di discriminazione, oscurantismo e regressione culturale».
Sarà, ma a noi sembra regressione culturale quella che svilisce le donne illudendole che i cortei come quelli dello scorso venerdì possano realmente “liberarle” mentre non fa che incatenarle a un femminismo che le riduce ai propri istinti e le allontana dalla pienezza di vita che solo Dio può dare.
— Álvaro J. Amoretti (@aamorettivp) 8 marzo 2019